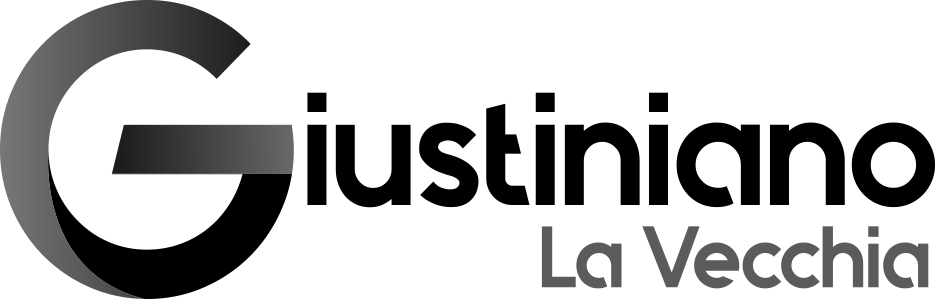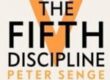Chi sono davvero i NEET?
In Italia si parla sempre più spesso di giovani che non studiano, non lavorano e non si formano.
Li chiamiamo NEET, acronimo di Not in Employment, Education or Training: giovani tra i 15 e i 29 anni fuori da ogni percorso educativo, formativo o professionale.
È una definizione utilizzata anche da Eurostat e OCSE, utile per monitorare quanto una società riesca a includere davvero le sue nuove generazioni.
Numeri che raccontano più di una crisi
Nel 2023, il 16,1% dei giovani italiani rientrava in questa categoria.
Un dato in lieve calo rispetto al 2022 (19%), ma ancora nettamente sopra la media europea, che si ferma all’11,2%. Nelle regioni del Mezzogiorno, si arriva a sfiorare il 28%.
Allo stesso tempo, l’abbandono scolastico colpisce ancora il 10,5% dei giovani tra i 18 e i 24 anni (fonte ISTAT).
Ma questi numeri non sono un semplice dato statistico: sono la fotografia di un fallimento educativo e sociale.
Un sistema che non orienta, non ascolta
Questi giovani non sono il problema. Sono il sintomo.
Il sintomo di un sistema educativo spesso rigido, lontano dal presente, incapace di offrire orientamento autentico.
Il riflesso di un mercato del lavoro che pretende esperienza da chi non ha avuto modo di farsela, e che raramente forma davvero.
E soprattutto, il risultato di una rete adulta che troppo spesso giudica prima di capire: famiglie assenti o iper-controllanti, docenti chiusi nella propria autorità, imprese cieche di fronte al talento e politici incapaci di ascoltare.
Hikikomori: quando l’isolamento diventa totale
C’è anche chi, più drammaticamente, decide di sparire.
Sono gli Hikikomori, adolescenti o post-adolescenti che si chiudono nella loro stanza, spesso per mesi o anni, evitando ogni contatto con il mondo esterno.
Secondo l’Associazione Hikikomori Italia, si stimano oltre 100.000 casi nel nostro Paese. Dietro queste chiusure ci sono ansia, depressione, fallimenti relazionali, delusioni scolastiche, pressioni familiari.
E anche qui, la responsabilità non può essere solo loro. È un problema collettivo.
Il problema non è economico, ma culturale
Non si tratta solo di mancanza di lavoro o opportunità. Il problema è culturale, relazionale, educativo.
Riguarda tutti noi: genitori, insegnanti, imprenditori, istituzioni.
Se un ragazzo decide che il mondo là fuori non fa per lui, non è solo lui a crollare. È l’intero sistema che ha smesso di accoglierlo, ascoltarlo, includerlo.
Serve un cambiamento radicale
Non possiamo più limitarci a curare i sintomi.
Abbiamo bisogno di una scuola che insegni a vivere, non solo a ripetere.
Di un lavoro che accolga, formi e accompagni, invece di escludere.
Di una società che smetta di dire “al mio tempo era peggio”, e cominci finalmente ad ascoltare.
Perché se tanti giovani oggi rinunciano a partecipare, non è perché sono deboli.
È perché nessuno ha mai davvero restituito loro la forza che cercavano.