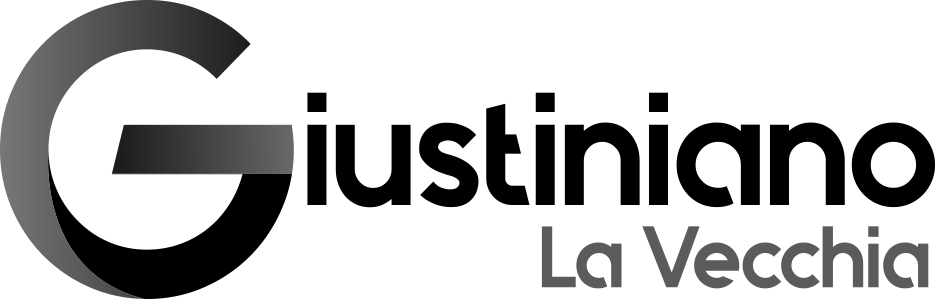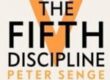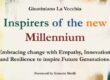C’è un tempo per imparare e un tempo per disimparare.
E oggi, forse, è arrivato il secondo.
Viviamo in un’epoca in cui il sapere invecchia in mesi, le competenze diventano liquide e il futuro non può più essere previsto, ma solo abitato.
Eppure, continuiamo a comportarci come se bastasse un corso, una piattaforma o un manuale per comprendere il mondo che cambia.
Le nuove generazioni non vogliono più sedersi ad ascoltare. Non cercano mentori che spieghino “come si fa”, ma ispiratori e ispiratrici del futuro che mostrino “come si diventa”.
Non chiedono regole, ma esempi. Non desiderano essere formate, ma coinvolte.
Il modello formativo è al capolinea
Il modello formativo tradizionale, costruito su efficienza, controllo e ripetizione, è arrivato al limite della sua utilità.
Come scrive Gary Hamel in Humanocracy le organizzazioni che restano prigioniere della prevedibilità finiscono per soffocare la creatività e la responsabilità individuale.
Continuare a copiare il passato significa, in fondo, sottomettersi al futuro.
In Italia, la spesa per la formazione continua vale appena lo 0,19% del PIL, contro una media europea che supera il 4%.
È quanto emerge dai più recenti dati della Commissione Europea (Education and Training Monitor 2024) e dell’OCSE (2025), che collocano il nostro Paese tra gli ultimi in Europa per investimenti nel capitale umano.
Quando la formazione è trattata come un costo o un incentivo da sfruttare, e non come un atto evolutivo, il vero valore si perde: le persone.
Dalla formazione al risveglio delle coscienze
Le nuove generazioni non chiedono qualcuno che dica loro “segui la lezione e impara”.
Domandano: “quale errore possiamo fare insieme? quale mondo possiamo costruire?”.
È una domanda semplice e rivoluzionaria, perché sposta il baricentro dall’obbedienza alla co-creazione.
Secondo l’OECD Report “Understanding Skill Gaps in Firms” (2024), in Italia il 37% delle imprese segnala lacune tra le competenze richieste e quelle disponibili nei propri dipendenti.
Questo dato dimostra quanto il modello tradizionale sia ormai scollegato dai bisogni reali del lavoro e delle persone.
Le organizzazioni destinate a durare non saranno quelle che accumulano corsi, ma quelle che costruiscono ecosistemi di apprendimento continuo, spazi di creatività, vulnerabilità e sperimentazione.
Sono questi i luoghi dove si liberano idee ed energia, si impara sbagliando, ascoltando e ricominciando.
Liberare, non solo formare
La vera innovazione non nasce dal prodotto, ma dal coraggio di reinventare la gestione stessa, le relazioni e il senso del lavoro.
Oggi la domanda non è più “quanto formiamo?”, ma “quanto liberiamo?”.
Liberiamo tempo, fiducia, spazio, ascolto.
Perché l’apprendimento autentico nasce solo dove c’è libertà.
Domani non sarà costruito dai più preparati, ma dai più presenti.
A fare la differenza non saranno quelli che sanno tutto, ma chi ha il coraggio di disimparare ciò che non serve più.
Forse è questo il nuovo punto di partenza: passare da formare menti a risvegliare coscienze, da “ti insegno” a “ti affianco e scopriamolo insieme”, da metodo stabile a esperienza fluida.
E non servono mappe del passato per orientarsi in ciò che viene: basta lo sguardo vivo di chi sa che ogni giorno è un giorno buono per ricominciare a imparare davvero.
Fonti e riferimenti
-
Gary Hamel & Michele Zanini, Humanocracy: Creating Organizations as Amazing as the People Inside Them, Harvard Business Review Press, 2020.
-
European Commission, Education and Training Monitor 2024 – Italy Country Report: link
-
OECD (2024), Understanding Skill Gaps in Firms: link
-
OECD (2025), The Role of Subnational Governments in Adult Skills Systems: Italy: link
-
Cognitive Market Research (2025), Europe Corporate Training Industry Report: link